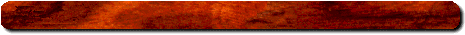itinerari
itinerari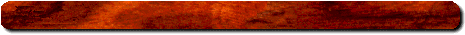

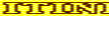

Di origini incerte, il Castello di Vigevano è già citato in documenti anteriori al Mille, forse come modesta cerchia muraria che racchiudeva il primitivo borgo di "Vicogeboin".  L'aspetto attuale è frutto di numerosi interventi iniziati attorno al 1300, prima dai Torriani, poi dai Visconti e, con la sua elevazione a residenza ducale, dagli Sforza. Tra il 1341 ed il 1347, Luchino Visconti, podestê di Vigevano e duca di Milano, fece costruire il maschio quadrilatero, la Rocca di Belreguardo (ora Rocca Vecchia) e la Strada Coperta che, progettata da Giacomo da Cozzo e Giovanni da Ferrara, metteva in comunicazione Castello e Rocca scavalcando le case del borgo. I lavori proseguirono poi con Galeazzo Maria Sforza e, soprattutto, con Ludovico il Moro, che si servì dell'opera di Donato Bramante e Leonardo da Vinci per trasformare il turrito maschio visconteo in una leggiadra residenza ducale dotata di eleganti falconiere, suggestive loggie per le dame e magnifiche scuderie. Conclusa la parentesi sforzesca nel 1535 con la morte del duca Francesco II, Vigevano passò sotto la diretta dominazione di Madrid ed il Castello perse il ruolo di residenza principesca. Ridotto a caserma nel 1714 subì gravi manomissioni. Interrato il fossato che circondava il maschio e abbattuto il revellino con ponte levatoio che lo separava dal resto del cortile, tra il 1857 ed il 1867 sopportò altre vistose manomissioni nel maschio e tra le scuderie con l'introduzione di elementi neogotici. La visita Se si accede al cortile del Castello attraverso l'atrio della Torre, l'immenso "piazzone", occupato fino alla metà del trecento dalle case del borgo medioevale, ci appare chiuso sulla destra dalle scuderie: tre edifici a due piani che si susseguono con le facciate decorate di ciò che resta del quattrocentesco graffito. La prima scuderia è detta di Ludovico il Moro (o manica lunga), perchè fu fatta da lui costruire nel 1490 per i cavalli del "carissimo nipote Gian Galeazzo". L'ambiente, splendido per euritmina, misura 92 metri di lunghezza e 12 di larghezza, è tripartito da colonne di serizzo con basi e capitelli finemente lavorati e ricoperto con volte a crociera. Al piano superiore si affiancavano gli alloggi dei palafrenieri e dei paggi. La sua realizzazione richiama indiscutibilmente alla memoria la "polita stalla" leonardesca del Codice Tivulziano e del Ms. B. Segue la seconda scuderia di m. 46 x 9, costruita nel 1473 per disposizione del duca Galeazzo Maria, pur'essa a tre navate e poggiante su colonne di serizzo come la precedente. L'atrio che interrompe la continuità di questi edifici per dare accesso carrabile al Castello è frutto di un cervellotico intervento in chiave neogotica praticato dopo il 1857 dal colonnello Inverardi del genio militare. La terza scuderia, la più piccola, mostra chiaramente di essere la ristrutturazione sforzesca di un edificio preesistente, e come le precedenti è suddivisa in tre navate poggianti su esili colonne con capitelli "unghiati" ed a "testa di cavallo", meno accurati di quelli presenti nelle precedenti scuderie.
L'aspetto attuale è frutto di numerosi interventi iniziati attorno al 1300, prima dai Torriani, poi dai Visconti e, con la sua elevazione a residenza ducale, dagli Sforza. Tra il 1341 ed il 1347, Luchino Visconti, podestê di Vigevano e duca di Milano, fece costruire il maschio quadrilatero, la Rocca di Belreguardo (ora Rocca Vecchia) e la Strada Coperta che, progettata da Giacomo da Cozzo e Giovanni da Ferrara, metteva in comunicazione Castello e Rocca scavalcando le case del borgo. I lavori proseguirono poi con Galeazzo Maria Sforza e, soprattutto, con Ludovico il Moro, che si servì dell'opera di Donato Bramante e Leonardo da Vinci per trasformare il turrito maschio visconteo in una leggiadra residenza ducale dotata di eleganti falconiere, suggestive loggie per le dame e magnifiche scuderie. Conclusa la parentesi sforzesca nel 1535 con la morte del duca Francesco II, Vigevano passò sotto la diretta dominazione di Madrid ed il Castello perse il ruolo di residenza principesca. Ridotto a caserma nel 1714 subì gravi manomissioni. Interrato il fossato che circondava il maschio e abbattuto il revellino con ponte levatoio che lo separava dal resto del cortile, tra il 1857 ed il 1867 sopportò altre vistose manomissioni nel maschio e tra le scuderie con l'introduzione di elementi neogotici. La visita Se si accede al cortile del Castello attraverso l'atrio della Torre, l'immenso "piazzone", occupato fino alla metà del trecento dalle case del borgo medioevale, ci appare chiuso sulla destra dalle scuderie: tre edifici a due piani che si susseguono con le facciate decorate di ciò che resta del quattrocentesco graffito. La prima scuderia è detta di Ludovico il Moro (o manica lunga), perchè fu fatta da lui costruire nel 1490 per i cavalli del "carissimo nipote Gian Galeazzo". L'ambiente, splendido per euritmina, misura 92 metri di lunghezza e 12 di larghezza, è tripartito da colonne di serizzo con basi e capitelli finemente lavorati e ricoperto con volte a crociera. Al piano superiore si affiancavano gli alloggi dei palafrenieri e dei paggi. La sua realizzazione richiama indiscutibilmente alla memoria la "polita stalla" leonardesca del Codice Tivulziano e del Ms. B. Segue la seconda scuderia di m. 46 x 9, costruita nel 1473 per disposizione del duca Galeazzo Maria, pur'essa a tre navate e poggiante su colonne di serizzo come la precedente. L'atrio che interrompe la continuità di questi edifici per dare accesso carrabile al Castello è frutto di un cervellotico intervento in chiave neogotica praticato dopo il 1857 dal colonnello Inverardi del genio militare. La terza scuderia, la più piccola, mostra chiaramente di essere la ristrutturazione sforzesca di un edificio preesistente, e come le precedenti è suddivisa in tre navate poggianti su esili colonne con capitelli "unghiati" ed a "testa di cavallo", meno accurati di quelli presenti nelle precedenti scuderie. Al fabbricato della terza scuderia si appoggia la Falconiera, probabilmente costruita nel 1300, ma ristrutturata da Bramante nel 1492. Sottopassata la Falconiera si accede ad un cortiletto da cui una suggestiva rampa coperta sale alla Falconiera ed al Pontile, un aereo passaggio di chiara impronta bramantesca che collega la Falconiera al Maschio o Palazzo Ducale. Il Maschio è il fabbricato più imponente del Castello e risale alla metà del secolo XIV, quando si componeva di tre corpi di fabbrica: uno centrale (duplicato in epoca sforzesca per ragioni di statica) e due maniche rivolte verso il cortile principale. Fino alla metê del 1700 era separato dal resto del "piazzone" da un fossato e da un alto muraglione con revellino centrale e ponte levatoio. Del muro si notano ancora gli appigli sulle pareti delle due maniche laterali. Una merlatura ghibellina tamponata e ricoperta con il tetto nel 1700 coronava l'edificio. Successivamente il fabbricato ha subito rifacimenti e modifiche: i muri vennero ispessiti e le finestre decorate e modanate in cotto. La facciata frontale è stata pesantemente modificata dopo il 1857 dal già citato colonnello Inverardi, pare in seguito ad alcuni crolli che avevano reso precaria la stabilità della costruzione. Fu in tale occasione che vennero aggiunte lesene in cotto e spostate le finestre per riassettarle dopo la soppressione dello scalone in legno che sul lato sinistro saliva ai piani nobili. Dello stesso periodo è l'aggiunta dell'ultimo ordine di finestre in stile Tudor, create per illuminare i nuovi locali ricavati con l'innalzamento del tetto. Dal portale situato nell'angolo sinistro della facciata del Maschio si accede alla "Strada Coperta", lunga 164 metri e larga 7,30, che superando il "Portone" scavalca le case sottostanti. Essa mette in comunicazione il Castello con ciò che resta dell'antica Rocca Vecchia fatta erigere da Luchino Visconti ed andata distrutta durante l'assedio sforzesco del 1449. Sul sedime della Rocca sorge la Cavallerizza, un enorme capannone a capriate costruito nel 1836 per ospitare i reparti di cavalleria dell'Esercito Sardo. Nel far ritorno al Castello dalla Strada Coperta si osservi la facciata posteriore del Maschio (sulla sinistra), con due ordini di finestre in più della facciata principale per il dislivello esistente tra il cortile del Castello e questa parte dell'abitato. Notare anche la Loggia delle Dame, di sicura attribuzione bramantesca, murata e sopralzata alla fine del 1700 per ragioni militari. Il sottostante cortile che si elevava leggiadro fino alla Loggia è stato sciaguratamente sventrato e sterrato nel secolo scorso. Ritornati sul "piazzone" notare a destra gli edifici sforzeschi che si ricongiungono alla Torre e che, sopralzati di un piano nel 1872, sono noti col nome di "ex Circolo Ufficiali".
Al fabbricato della terza scuderia si appoggia la Falconiera, probabilmente costruita nel 1300, ma ristrutturata da Bramante nel 1492. Sottopassata la Falconiera si accede ad un cortiletto da cui una suggestiva rampa coperta sale alla Falconiera ed al Pontile, un aereo passaggio di chiara impronta bramantesca che collega la Falconiera al Maschio o Palazzo Ducale. Il Maschio è il fabbricato più imponente del Castello e risale alla metà del secolo XIV, quando si componeva di tre corpi di fabbrica: uno centrale (duplicato in epoca sforzesca per ragioni di statica) e due maniche rivolte verso il cortile principale. Fino alla metê del 1700 era separato dal resto del "piazzone" da un fossato e da un alto muraglione con revellino centrale e ponte levatoio. Del muro si notano ancora gli appigli sulle pareti delle due maniche laterali. Una merlatura ghibellina tamponata e ricoperta con il tetto nel 1700 coronava l'edificio. Successivamente il fabbricato ha subito rifacimenti e modifiche: i muri vennero ispessiti e le finestre decorate e modanate in cotto. La facciata frontale è stata pesantemente modificata dopo il 1857 dal già citato colonnello Inverardi, pare in seguito ad alcuni crolli che avevano reso precaria la stabilità della costruzione. Fu in tale occasione che vennero aggiunte lesene in cotto e spostate le finestre per riassettarle dopo la soppressione dello scalone in legno che sul lato sinistro saliva ai piani nobili. Dello stesso periodo è l'aggiunta dell'ultimo ordine di finestre in stile Tudor, create per illuminare i nuovi locali ricavati con l'innalzamento del tetto. Dal portale situato nell'angolo sinistro della facciata del Maschio si accede alla "Strada Coperta", lunga 164 metri e larga 7,30, che superando il "Portone" scavalca le case sottostanti. Essa mette in comunicazione il Castello con ciò che resta dell'antica Rocca Vecchia fatta erigere da Luchino Visconti ed andata distrutta durante l'assedio sforzesco del 1449. Sul sedime della Rocca sorge la Cavallerizza, un enorme capannone a capriate costruito nel 1836 per ospitare i reparti di cavalleria dell'Esercito Sardo. Nel far ritorno al Castello dalla Strada Coperta si osservi la facciata posteriore del Maschio (sulla sinistra), con due ordini di finestre in più della facciata principale per il dislivello esistente tra il cortile del Castello e questa parte dell'abitato. Notare anche la Loggia delle Dame, di sicura attribuzione bramantesca, murata e sopralzata alla fine del 1700 per ragioni militari. Il sottostante cortile che si elevava leggiadro fino alla Loggia è stato sciaguratamente sventrato e sterrato nel secolo scorso. Ritornati sul "piazzone" notare a destra gli edifici sforzeschi che si ricongiungono alla Torre e che, sopralzati di un piano nel 1872, sono noti col nome di "ex Circolo Ufficiali".
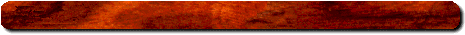
 |  |
| Indietro | Inizio |


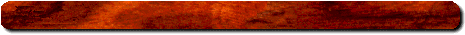

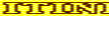

 L'aspetto attuale è frutto di numerosi interventi iniziati attorno al 1300, prima dai Torriani, poi dai Visconti e, con la sua elevazione a residenza ducale, dagli Sforza. Tra il 1341 ed il 1347, Luchino Visconti, podestê di Vigevano e duca di Milano, fece costruire il maschio quadrilatero, la Rocca di Belreguardo (ora Rocca Vecchia) e la Strada Coperta che, progettata da Giacomo da Cozzo e Giovanni da Ferrara, metteva in comunicazione Castello e Rocca scavalcando le case del borgo. I lavori proseguirono poi con Galeazzo Maria Sforza e, soprattutto, con Ludovico il Moro, che si servì dell'opera di Donato Bramante e Leonardo da Vinci per trasformare il turrito maschio visconteo in una leggiadra residenza ducale dotata di eleganti falconiere, suggestive loggie per le dame e magnifiche scuderie. Conclusa la parentesi sforzesca nel 1535 con la morte del duca Francesco II, Vigevano passò sotto la diretta dominazione di Madrid ed il Castello perse il ruolo di residenza principesca. Ridotto a caserma nel 1714 subì gravi manomissioni. Interrato il fossato che circondava il maschio e abbattuto il revellino con ponte levatoio che lo separava dal resto del cortile, tra il 1857 ed il 1867 sopportò altre vistose manomissioni nel maschio e tra le scuderie con l'introduzione di elementi neogotici. La visita Se si accede al cortile del Castello attraverso l'atrio della Torre, l'immenso "piazzone", occupato fino alla metà del trecento dalle case del borgo medioevale, ci appare chiuso sulla destra dalle scuderie: tre edifici a due piani che si susseguono con le facciate decorate di ciò che resta del quattrocentesco graffito. La prima scuderia è detta di Ludovico il Moro (o manica lunga), perchè fu fatta da lui costruire nel 1490 per i cavalli del "carissimo nipote Gian Galeazzo". L'ambiente, splendido per euritmina, misura 92 metri di lunghezza e 12 di larghezza, è tripartito da colonne di serizzo con basi e capitelli finemente lavorati e ricoperto con volte a crociera. Al piano superiore si affiancavano gli alloggi dei palafrenieri e dei paggi. La sua realizzazione richiama indiscutibilmente alla memoria la "polita stalla" leonardesca del Codice Tivulziano e del Ms. B. Segue la seconda scuderia di m. 46 x 9, costruita nel 1473 per disposizione del duca Galeazzo Maria, pur'essa a tre navate e poggiante su colonne di serizzo come la precedente. L'atrio che interrompe la continuità di questi edifici per dare accesso carrabile al Castello è frutto di un cervellotico intervento in chiave neogotica praticato dopo il 1857 dal colonnello Inverardi del genio militare. La terza scuderia, la più piccola, mostra chiaramente di essere la ristrutturazione sforzesca di un edificio preesistente, e come le precedenti è suddivisa in tre navate poggianti su esili colonne con capitelli "unghiati" ed a "testa di cavallo", meno accurati di quelli presenti nelle precedenti scuderie.
L'aspetto attuale è frutto di numerosi interventi iniziati attorno al 1300, prima dai Torriani, poi dai Visconti e, con la sua elevazione a residenza ducale, dagli Sforza. Tra il 1341 ed il 1347, Luchino Visconti, podestê di Vigevano e duca di Milano, fece costruire il maschio quadrilatero, la Rocca di Belreguardo (ora Rocca Vecchia) e la Strada Coperta che, progettata da Giacomo da Cozzo e Giovanni da Ferrara, metteva in comunicazione Castello e Rocca scavalcando le case del borgo. I lavori proseguirono poi con Galeazzo Maria Sforza e, soprattutto, con Ludovico il Moro, che si servì dell'opera di Donato Bramante e Leonardo da Vinci per trasformare il turrito maschio visconteo in una leggiadra residenza ducale dotata di eleganti falconiere, suggestive loggie per le dame e magnifiche scuderie. Conclusa la parentesi sforzesca nel 1535 con la morte del duca Francesco II, Vigevano passò sotto la diretta dominazione di Madrid ed il Castello perse il ruolo di residenza principesca. Ridotto a caserma nel 1714 subì gravi manomissioni. Interrato il fossato che circondava il maschio e abbattuto il revellino con ponte levatoio che lo separava dal resto del cortile, tra il 1857 ed il 1867 sopportò altre vistose manomissioni nel maschio e tra le scuderie con l'introduzione di elementi neogotici. La visita Se si accede al cortile del Castello attraverso l'atrio della Torre, l'immenso "piazzone", occupato fino alla metà del trecento dalle case del borgo medioevale, ci appare chiuso sulla destra dalle scuderie: tre edifici a due piani che si susseguono con le facciate decorate di ciò che resta del quattrocentesco graffito. La prima scuderia è detta di Ludovico il Moro (o manica lunga), perchè fu fatta da lui costruire nel 1490 per i cavalli del "carissimo nipote Gian Galeazzo". L'ambiente, splendido per euritmina, misura 92 metri di lunghezza e 12 di larghezza, è tripartito da colonne di serizzo con basi e capitelli finemente lavorati e ricoperto con volte a crociera. Al piano superiore si affiancavano gli alloggi dei palafrenieri e dei paggi. La sua realizzazione richiama indiscutibilmente alla memoria la "polita stalla" leonardesca del Codice Tivulziano e del Ms. B. Segue la seconda scuderia di m. 46 x 9, costruita nel 1473 per disposizione del duca Galeazzo Maria, pur'essa a tre navate e poggiante su colonne di serizzo come la precedente. L'atrio che interrompe la continuità di questi edifici per dare accesso carrabile al Castello è frutto di un cervellotico intervento in chiave neogotica praticato dopo il 1857 dal colonnello Inverardi del genio militare. La terza scuderia, la più piccola, mostra chiaramente di essere la ristrutturazione sforzesca di un edificio preesistente, e come le precedenti è suddivisa in tre navate poggianti su esili colonne con capitelli "unghiati" ed a "testa di cavallo", meno accurati di quelli presenti nelle precedenti scuderie. Al fabbricato della terza scuderia si appoggia la Falconiera, probabilmente costruita nel 1300, ma ristrutturata da Bramante nel 1492. Sottopassata la Falconiera si accede ad un cortiletto da cui una suggestiva rampa coperta sale alla Falconiera ed al Pontile, un aereo passaggio di chiara impronta bramantesca che collega la Falconiera al Maschio o Palazzo Ducale. Il Maschio è il fabbricato più imponente del Castello e risale alla metà del secolo XIV, quando si componeva di tre corpi di fabbrica: uno centrale (duplicato in epoca sforzesca per ragioni di statica) e due maniche rivolte verso il cortile principale. Fino alla metê del 1700 era separato dal resto del "piazzone" da un fossato e da un alto muraglione con revellino centrale e ponte levatoio. Del muro si notano ancora gli appigli sulle pareti delle due maniche laterali. Una merlatura ghibellina tamponata e ricoperta con il tetto nel 1700 coronava l'edificio. Successivamente il fabbricato ha subito rifacimenti e modifiche: i muri vennero ispessiti e le finestre decorate e modanate in cotto. La facciata frontale è stata pesantemente modificata dopo il 1857 dal già citato colonnello Inverardi, pare in seguito ad alcuni crolli che avevano reso precaria la stabilità della costruzione. Fu in tale occasione che vennero aggiunte lesene in cotto e spostate le finestre per riassettarle dopo la soppressione dello scalone in legno che sul lato sinistro saliva ai piani nobili. Dello stesso periodo è l'aggiunta dell'ultimo ordine di finestre in stile Tudor, create per illuminare i nuovi locali ricavati con l'innalzamento del tetto. Dal portale situato nell'angolo sinistro della facciata del Maschio si accede alla "Strada Coperta", lunga 164 metri e larga 7,30, che superando il "Portone" scavalca le case sottostanti. Essa mette in comunicazione il Castello con ciò che resta dell'antica Rocca Vecchia fatta erigere da Luchino Visconti ed andata distrutta durante l'assedio sforzesco del 1449. Sul sedime della Rocca sorge la Cavallerizza, un enorme capannone a capriate costruito nel 1836 per ospitare i reparti di cavalleria dell'Esercito Sardo. Nel far ritorno al Castello dalla Strada Coperta si osservi la facciata posteriore del Maschio (sulla sinistra), con due ordini di finestre in più della facciata principale per il dislivello esistente tra il cortile del Castello e questa parte dell'abitato. Notare anche la Loggia delle Dame, di sicura attribuzione bramantesca, murata e sopralzata alla fine del 1700 per ragioni militari. Il sottostante cortile che si elevava leggiadro fino alla Loggia è stato sciaguratamente sventrato e sterrato nel secolo scorso. Ritornati sul "piazzone" notare a destra gli edifici sforzeschi che si ricongiungono alla Torre e che, sopralzati di un piano nel 1872, sono noti col nome di "ex Circolo Ufficiali".
Al fabbricato della terza scuderia si appoggia la Falconiera, probabilmente costruita nel 1300, ma ristrutturata da Bramante nel 1492. Sottopassata la Falconiera si accede ad un cortiletto da cui una suggestiva rampa coperta sale alla Falconiera ed al Pontile, un aereo passaggio di chiara impronta bramantesca che collega la Falconiera al Maschio o Palazzo Ducale. Il Maschio è il fabbricato più imponente del Castello e risale alla metà del secolo XIV, quando si componeva di tre corpi di fabbrica: uno centrale (duplicato in epoca sforzesca per ragioni di statica) e due maniche rivolte verso il cortile principale. Fino alla metê del 1700 era separato dal resto del "piazzone" da un fossato e da un alto muraglione con revellino centrale e ponte levatoio. Del muro si notano ancora gli appigli sulle pareti delle due maniche laterali. Una merlatura ghibellina tamponata e ricoperta con il tetto nel 1700 coronava l'edificio. Successivamente il fabbricato ha subito rifacimenti e modifiche: i muri vennero ispessiti e le finestre decorate e modanate in cotto. La facciata frontale è stata pesantemente modificata dopo il 1857 dal già citato colonnello Inverardi, pare in seguito ad alcuni crolli che avevano reso precaria la stabilità della costruzione. Fu in tale occasione che vennero aggiunte lesene in cotto e spostate le finestre per riassettarle dopo la soppressione dello scalone in legno che sul lato sinistro saliva ai piani nobili. Dello stesso periodo è l'aggiunta dell'ultimo ordine di finestre in stile Tudor, create per illuminare i nuovi locali ricavati con l'innalzamento del tetto. Dal portale situato nell'angolo sinistro della facciata del Maschio si accede alla "Strada Coperta", lunga 164 metri e larga 7,30, che superando il "Portone" scavalca le case sottostanti. Essa mette in comunicazione il Castello con ciò che resta dell'antica Rocca Vecchia fatta erigere da Luchino Visconti ed andata distrutta durante l'assedio sforzesco del 1449. Sul sedime della Rocca sorge la Cavallerizza, un enorme capannone a capriate costruito nel 1836 per ospitare i reparti di cavalleria dell'Esercito Sardo. Nel far ritorno al Castello dalla Strada Coperta si osservi la facciata posteriore del Maschio (sulla sinistra), con due ordini di finestre in più della facciata principale per il dislivello esistente tra il cortile del Castello e questa parte dell'abitato. Notare anche la Loggia delle Dame, di sicura attribuzione bramantesca, murata e sopralzata alla fine del 1700 per ragioni militari. Il sottostante cortile che si elevava leggiadro fino alla Loggia è stato sciaguratamente sventrato e sterrato nel secolo scorso. Ritornati sul "piazzone" notare a destra gli edifici sforzeschi che si ricongiungono alla Torre e che, sopralzati di un piano nel 1872, sono noti col nome di "ex Circolo Ufficiali".