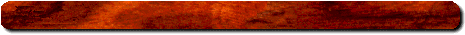itinerari
itinerari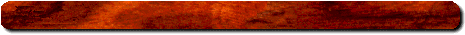

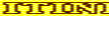
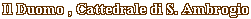
La conferma dell'esistenza in Vigevano di una basilica dedicata a Sant'Ambrogio la troviamo in documenti del 963 e 967, conservati nell'Archivio Capitolare di Novara. L'attuale costruzione attuata su disegno di Antonio da Lonate fu iniziata nel 1532 per volere del duca Francesco II Sforza  sul sedime di una chiesa del 1465, della quale furono conservati l'abside ed il coro. Con la morte del duca avvenuta nel 1535, i lavori procedettero molto a rilento per mancanza di fondi, e solamente nel 1606 furono completate le strutture principali. Nel 1612 ci fu la consacrazione del tempio e nel 1680 l'erezione della nuova facciata barocca ideata dal vescovo Caramuel. La cupola fu innalzata nel 1716 e la Sacrestia Capitolare, già costruita nel 1534, fu arredata nel 1753, più di due secoli dopo. Il campanile, ricavato nel 1450 sui resti di una preesistente torre trecentesca, e ancora sopralzato di sette metri nel 1818, fu con l'occasione coronato di merli ghibellini. La facciata La facciata progettata dal vescovo Caramuel Lobkowitz nel 1680 fu restaurata dall'architetto Moretti nel 1910. Sul fastigio della stessa sono state riordinate le statue della Madonna, di due angeli, di Sant'Ambrogio, di San Carlo e due obelischi di granito. L'ingegnosa disposizione della nuova facciata, costruita in asse con la piazza anzichè con l'interno della chiesa, è stata suddivisa in quattro parti, con quattro portali, per nascondere l'accesso alla piazza di via Roma (a sinistra) e per mimetizzare un cortiletto posto ai piedi del campanile dotato di fontana battesimale dal 1970 (a destra). L'interno L'interno della cattedrale, a croce latina, ha conservato gli originari caratteri rinascimentali, con tre navate sorrette da robusti pilastri sormontati da capitelli dorati.
sul sedime di una chiesa del 1465, della quale furono conservati l'abside ed il coro. Con la morte del duca avvenuta nel 1535, i lavori procedettero molto a rilento per mancanza di fondi, e solamente nel 1606 furono completate le strutture principali. Nel 1612 ci fu la consacrazione del tempio e nel 1680 l'erezione della nuova facciata barocca ideata dal vescovo Caramuel. La cupola fu innalzata nel 1716 e la Sacrestia Capitolare, già costruita nel 1534, fu arredata nel 1753, più di due secoli dopo. Il campanile, ricavato nel 1450 sui resti di una preesistente torre trecentesca, e ancora sopralzato di sette metri nel 1818, fu con l'occasione coronato di merli ghibellini. La facciata La facciata progettata dal vescovo Caramuel Lobkowitz nel 1680 fu restaurata dall'architetto Moretti nel 1910. Sul fastigio della stessa sono state riordinate le statue della Madonna, di due angeli, di Sant'Ambrogio, di San Carlo e due obelischi di granito. L'ingegnosa disposizione della nuova facciata, costruita in asse con la piazza anzichè con l'interno della chiesa, è stata suddivisa in quattro parti, con quattro portali, per nascondere l'accesso alla piazza di via Roma (a sinistra) e per mimetizzare un cortiletto posto ai piedi del campanile dotato di fontana battesimale dal 1970 (a destra). L'interno L'interno della cattedrale, a croce latina, ha conservato gli originari caratteri rinascimentali, con tre navate sorrette da robusti pilastri sormontati da capitelli dorati.
- La Navata Centrale presenta nella volta grandi affreschi dipinti nel 1857 dal pittore torinese Francesco Gonin raffiguranti "Sant'Ambrogio acclamato Vescovo", "La consacrazione di Sant'Ambrogio" e "Sant'Ambrogio che scaccia dal tempio l'imperatore Teodosio. Iniziando la visita dalla navata di destra, troviamo:
- Racchiuso entro una seicentesca cancellata in ferro battuto, il vecchio battistero, sovrastato da un elegante ciborio ottagonale di legno intagliato.
- La prima cappella è detta delCrocifisso (1) per la presenza del dipinto dellaCrocifissione firmato "Caesar Magnus 1531", donato alla Cattedrale da Francesco II Sforza il 10 marzo 1534. D'ispirazione leonardesca, l'opera sottolinea mirabilmente il volto raccolto e dolorante del Cristo avente la Madonna, la Maddalena, S. Girolamo e S. Giovanni raccolti sotto la Croce.
- Seguono le cappelle dedicate a S. Elisabetta (2) e ai SS. Filippo e Giacomo, protettori dei tessitori (3).
- Al termine della navata di destra, all'altezza del Transetto, si apre la cappella di S. Carlo (4), costruita nel 1581, tre anni dopo la visita apostolica del Santo a Vigevano. Nella cappella merita attenzione tra l'altro il settecentesco altare principale con la pala dipinta da Francesco Lorenzi, discepolo del Tiepolo. Gli affreschi del 1858 sono opera dei pittori Cesare Ferrari di Milano e Francesco Gonin di Torino. Sulla parete sinistra spicca un quadro proveniente dalla distrutta chiesa del Convento delle Grazie che rappresenta la Vergine col Figlio tra Santa Chiara ed il Beato Maccasolio. L'insigne opera datata 1502 viene attribuita a Macrino d'Alba. A fianco è notevole la tavola dipinta ad olio nel 1530 dal pittore vigevanese Bernardo Ferrari che rappresenta S. Tommaso di Canterbury, San Bernardino e Santa Chiara. Sulla parete destra sono notevoli un quadro di autore ignoto del '500, raffigurante il Vescovo Maurizio Pietra, ed un trittico del tardo '400 che rappresenta S. Agostino tra Santa Monica, S. Sempliciano e S. Ambrogio. I mosaici sono opera di Cesare Cassio della fabbrica di S. Pietro in Vaticano e risalgono al 1948.
- Nell'andito della Sacrestia Capitolare (5) si può ammirare un grande Crocifisso ligneo proveniente dalla collegiata di Sant'Ambrogio, opera del sec. XVI. Quindi, sulla destra, il monumento funebre di Galeazzo Pietra, primo vescovo di Vigevano, scolpito da Bernardo Romano nel 1550. Contro la cassa dell+organo spicca la grande tela cinquecentesca di Bernardo Ferrari raffigurante "L'apparizione di Sant'Ambrogio nella battaglia di Parabiago".
- La Sacrestia Maggiore o Capitolare (6) è sala pregevole ed austera. Alle pareti sono allineati magnifici mobili di noce lucido intagliati del 1753. La volta fu restaurata nel 1910 dai pittori vigevanesi Barni e Biggi. Alla parete frontale spicca un'originale e stupenda cornice lignea attribuita all'intaglio di Pietro da Sesto e alla doratura di Giuseppe da Vercelli, entro la quale è visibile una copia della "Pentecoste" di Bernardo Ferrari che, donata alla Cattedrale nel 1533 da Francesco II Sforza, è stata trafugata dai Francesi nel sec. XVII. Sotto il dipinto della Pentecoste troviamo "L'Ultima Cena", copia eseguita da G. B. Garberini dall'originale di Ferdinando Gatti che si trova in una sala del Palazzo Vescovile. Sulla destra della Sacrestia si accede al Museo del Tesoro del Duomo (vedere più avanti).
- Procedendo lungo la navata trasversale (7) si può ammirare la sovrastante cupola (alta 43 metri) con le otto Beatitudini affrescate da Francesco Gonin. Sopra l'Altar Maggiore, nel catino dell'abside, spicca la "Gloria di Sant'Ambrogio" affresco di Vitale Sala. Nella volta gli affreschi del Gonin sono dedicati alla SS. Trinità, a Santa Marcellina ed a San Satiro. Nei bracci del Transetto ci sono opere del pittore Gallo Gallina (1857), mentre nella lunetta sopra la porta della Sacrestia Maggiore si può ammirare "San Pietro che cammina sulle acque" di Mauro Conconi (1858) e, nella lunetta di sinistra, un affresco del pittore vigevanese G. B. Garberini.
- Nel Presbiterio e Coro (8) l'Altare Maggiore vecchio del 1600, già rifatto nel 1828, è stato sostituito da uno nuovo del 1971 che conserva un paliotto del 1700 con ricami paramentali del duca del 1500. Da menzionare l'organo che sostituisce quello del 1554 (forse di Costanzo Antignani), rifatto nel 1791 e nel 1845.
- Percorrendo la navata laterale sinistra in senso inverso incontriamo la Cappella della Madonna (9) che sopra l'Altare di marmo di Carrara, datato 1858, presenta la "Beata Vergine", uno squisito esempio di scultura lignea rinascimentale qui traslocata nel 1615 dalla demolita chiesa del Castello. In alto a sinistra, dietro la grata, sono conservate le spoglie del romano San Vito. Gli affreschi alle pareti sono del torinese Francesco Gonin.
- Dopo la Cappella di S. Giovanni Battista (10), troviamo la Cappella dei SS. Giacomo e Cristoforo(11), nella quale sopra l'altare spicca un magnifico polittico a tempera della fine del '400 attribuito ad Andrea Salaino allievo di Leonardo. Il polittico presenta la centro la "Madonna col Bambino" e sopra "La Deposizione". Ai lati troviamo a destra "S. Francesco" e "S. Cristoforo" e a sinistra "S. Giacomo e S. Domenico" che regge un modello di chiesa. _ senza ombra di dubbio l'opera di maggior pregio artistico conservata nella Cattedrale.
- Seguono la Cappella di S. Antonio (12), e la Cappella del Redentore (13), con un gran dipinto di Bernardino Gatti, detto il Soiaro, allievo del Correggio. Prima di uscire dalla chiesa notare nella controfacciata, sopra la bussola, la lapide che ricorda la consacrazione della Cattedrale (1612) ed i due medaglioni raffiguranti "Santa Cecilia" e "San Sebastiano".
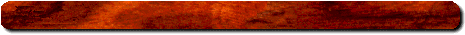
 |  |
| Indietro | Inizio |


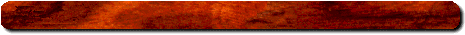

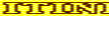
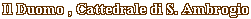
 sul sedime di una chiesa del 1465, della quale furono conservati l'abside ed il coro. Con la morte del duca avvenuta nel 1535, i lavori procedettero molto a rilento per mancanza di fondi, e solamente nel 1606 furono completate le strutture principali. Nel 1612 ci fu la consacrazione del tempio e nel 1680 l'erezione della nuova facciata barocca ideata dal vescovo Caramuel. La cupola fu innalzata nel 1716 e la Sacrestia Capitolare, già costruita nel 1534, fu arredata nel 1753, più di due secoli dopo. Il campanile, ricavato nel 1450 sui resti di una preesistente torre trecentesca, e ancora sopralzato di sette metri nel 1818, fu con l'occasione coronato di merli ghibellini. La facciata La facciata progettata dal vescovo Caramuel Lobkowitz nel 1680 fu restaurata dall'architetto Moretti nel 1910. Sul fastigio della stessa sono state riordinate le statue della Madonna, di due angeli, di Sant'Ambrogio, di San Carlo e due obelischi di granito. L'ingegnosa disposizione della nuova facciata, costruita in asse con la piazza anzichè con l'interno della chiesa, è stata suddivisa in quattro parti, con quattro portali, per nascondere l'accesso alla piazza di via Roma (a sinistra) e per mimetizzare un cortiletto posto ai piedi del campanile dotato di fontana battesimale dal 1970 (a destra). L'interno L'interno della cattedrale, a croce latina, ha conservato gli originari caratteri rinascimentali, con tre navate sorrette da robusti pilastri sormontati da capitelli dorati.
sul sedime di una chiesa del 1465, della quale furono conservati l'abside ed il coro. Con la morte del duca avvenuta nel 1535, i lavori procedettero molto a rilento per mancanza di fondi, e solamente nel 1606 furono completate le strutture principali. Nel 1612 ci fu la consacrazione del tempio e nel 1680 l'erezione della nuova facciata barocca ideata dal vescovo Caramuel. La cupola fu innalzata nel 1716 e la Sacrestia Capitolare, già costruita nel 1534, fu arredata nel 1753, più di due secoli dopo. Il campanile, ricavato nel 1450 sui resti di una preesistente torre trecentesca, e ancora sopralzato di sette metri nel 1818, fu con l'occasione coronato di merli ghibellini. La facciata La facciata progettata dal vescovo Caramuel Lobkowitz nel 1680 fu restaurata dall'architetto Moretti nel 1910. Sul fastigio della stessa sono state riordinate le statue della Madonna, di due angeli, di Sant'Ambrogio, di San Carlo e due obelischi di granito. L'ingegnosa disposizione della nuova facciata, costruita in asse con la piazza anzichè con l'interno della chiesa, è stata suddivisa in quattro parti, con quattro portali, per nascondere l'accesso alla piazza di via Roma (a sinistra) e per mimetizzare un cortiletto posto ai piedi del campanile dotato di fontana battesimale dal 1970 (a destra). L'interno L'interno della cattedrale, a croce latina, ha conservato gli originari caratteri rinascimentali, con tre navate sorrette da robusti pilastri sormontati da capitelli dorati.